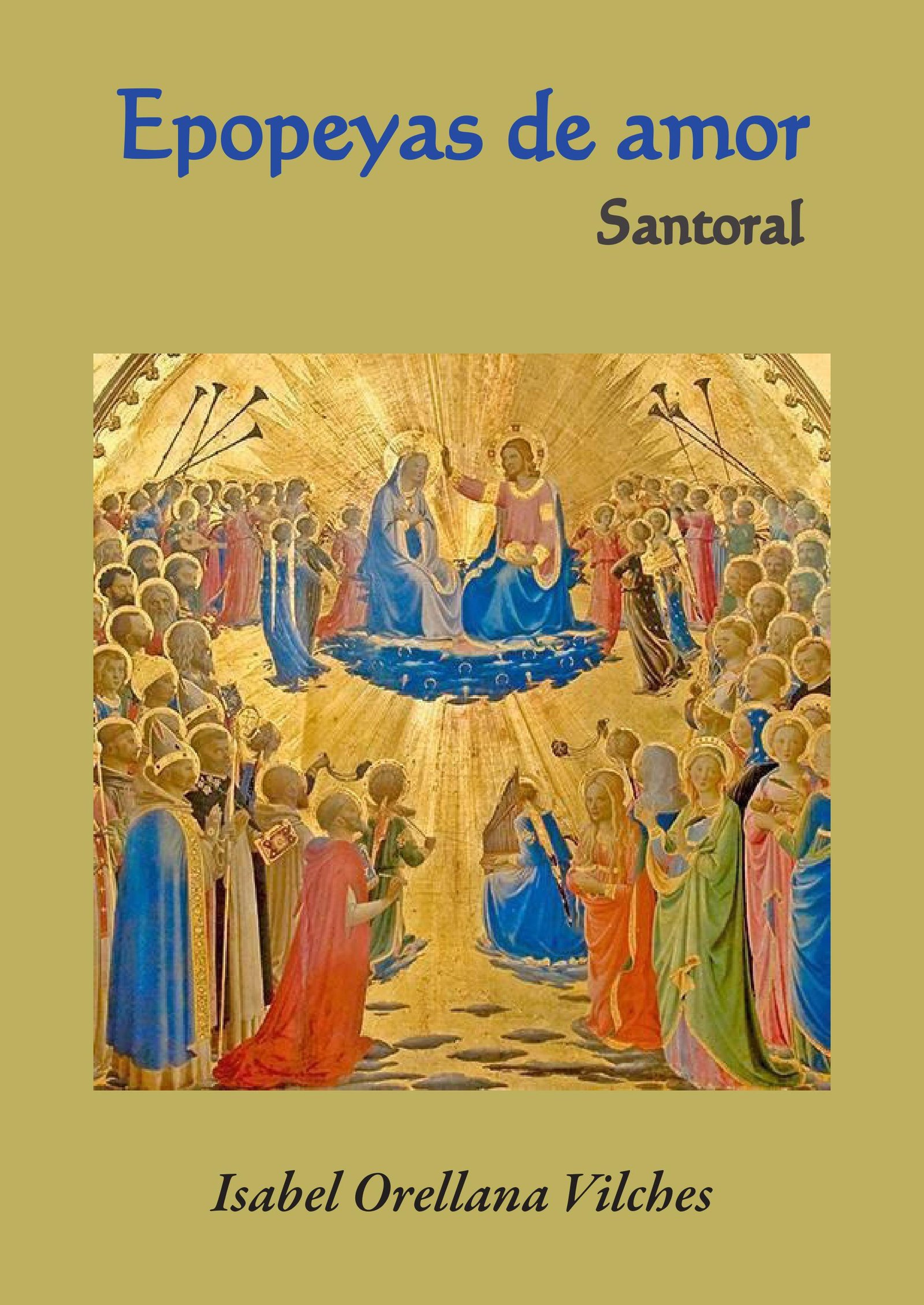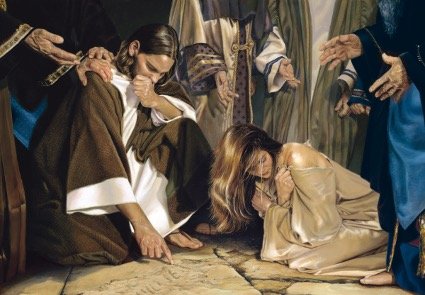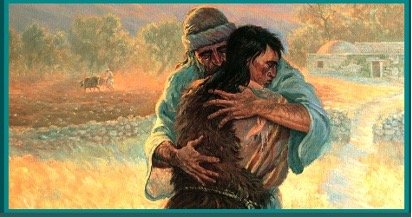“Papa e Dottore della Chiesa, nato in una famiglia di santi. Primo monaco ad occupare la Cattedra di Pietro. Un mistico, grande apostolo, saggio amministratore della Chiesa. Giovanni Paolo I lo evocò al momento di prendere possesso della sua carica di pontefice”
“E’ importante che il pastore sia puro nei suoi pensieri, irreprensibile nelle sue opere, discreto nel silenzio, vantaggioso nelle parole, compassionevole con tutti, più di tutti in alto nella contemplazione, compagno dei buoni per l’umiltà e fermo nel vegliare per la giustizia contro i vizi dei delinquenti. Che la preoccupazione delle cose esteriori non diminuisca l’attenzione per quelle interiori, e l’attenzione per quelle interiori non gli impedisca di provvedere alle esteriori”. Così questo grande pontefice, ed uno dei quattro dottori della Chiesa, descriveva nella sua “Regula pastoralis” le caratteristiche dei pastori che egli stesso aveva incarnato. Apparteneva ad una nobile e virtuosa famiglia romana. I suoi genitori, il senatore Gordiano e Silvia, ingrossano le file dei santi; sono venerati come tali. E le sue zie Tarsila ed Emiliana vissero una edificante vita ascetica come vergini consacrate. Inoltre, tra i suoi parenti ci furono due papi: Felice III ed Agapito.
Nacque verso l’anno 540 a Roma. Si specializzò in diritto, e concludendo gli studi fu famoso pretore di Roma per Giustino II. L’Italia era conquistata dai longobardi e poté constatare di prima mano le ferite di una barbarie che aveva ridotto l’urbe a rovine. Il lavoro, al quale si dedicava intensamente, non colmava i suoi profondi aneliti. Ma quando si trovò con due benedettini dell’abbazia di Montecassino, Costanzo e Simplicio, si aprì una luce nel suo cammino. Tuttavia, prima di decidersi a fare il passo unendosi ad essi, dovette scatenare una dura battaglia interiore. “Io differii per lungo tempo la grazia della conversione, cioè, della professione religiosa, e, anche dopo aver sentito l’ispirazione di un desiderio celeste, io credevo meglio conservare l’abito secolare. In questo tempo mi si manifestava nell’amore all’eternità quello che dovevo cercare, ma gli obblighi contratti mi incatenavano ed io non mi risolvevo a cambiare modo di vivere. E quando il mio spirito mi portava a non servire più il mondo se non in apparenza, molte attenzioni, nate dalle mie sollecitazioni per il mondo, cominciarono ad ingrandirsi a poco a poco contro il mio bene, fino al punto di trattenermi non solo al di fuori e in apparenza, ma quello che è più grave, nello spirito”.
Vinta ogni resistenza, in quattro anni di vita monastica recluso nel suo palazzo di monte Celio che convertì nel monastero di sant’Andrea, si forgiò il suo spirito con orazione e penitenze, e si dispose a compiere il proposito che Dio aveva previsto per lui. La sua virtù giunse all’orecchio di papa Pelagio II, che lo designò come suo “apocrisario” Ed a Costantinopoli sviluppò un’importante lotta contro i monofisiti, oltre ad agire diplomaticamente per ottenere dall’imperatore il conveniente appoggio per frenare i longobardi. Intanto, continuava a nutrire il suo spirito in felice convivenza insieme ai monaci. Ma l’anno 590 una terribile epidemia di peste falciò la vita di Pelagio II, ed egli fu scelto per succedergli. In quell’istante, il peso di una missione tanto alta lo spaventò, cercò di fuggire per evitarlo, ma finì per comprendere che la volontà divina aveva mosso quella dei suoi fratelli cardinali ed accettò l’imponente responsabilità che era caduta sulle sue spalle.
Da quel momento il suo saggio e brillante pontificato, veramente rinnovatore, come si poteva sperare da un uomo di orazione, umile e generoso, si sarebbe esteso a tutta la Chiesa. Fece vita della sua asserzione: “La prova dell’amore sta nelle opere. Dove l’amore esiste si operano grandi cose e quando smette di operare smette di esistere”. Fu un uomo abile, dialogante, conciliatore, che si avvicinò con fraterno spirito ai lontani dalla fede ed a coloro che sostenevano idee opposte. Così arrivò a penetrare nel cuore dei colonizzatori di diversi stati europei: sassoni, franchi, visigoti, longobardi, ecc. Propagò la fede con instancabile zelo apostolico, fortificò la sede di Roma, rinnovò il culto e la liturgia, diede impulso al canto conosciuto ora come gregoriano in suo onore, restaurò la Schola Cantorum, compose vari inni, edificò monasteri, scrisse numerose opere teologiche e centinaia di lettere. Insomma, un lascito tanto eccezionale che gli meritò il titolo di dottore della Chiesa.
Fu grande difensore degli oppressi. Vigilò affinché le risorse della Chiesa fossero destinate con impeccabile rigore, lontani da oscuri interessi particolari. Mantenne una corrispondenza degna di essere tenuta in considerazione con la regina bavara Teodolinda, fervente cattolica, con la quale ebbe dettagli di encomiabile delicatezza. Così le fece dono di alcune reliquie, molto pregiate nell’epoca, destinate alla basilica di san Giovanni Battista che fece erigere. Questo vincolo si ripercosse direttamente ed indirettamente nell’evangelizzazione, oltre a propiziare la pace tra longobardi e bizantini. Nel lavoro apostolico di Gregorio c’è una pagina particolarmente gloriosa: la conversione degli anglosassoni. Fu lui a ideare l’evangelizzazione dell’Inghilterra attraverso missionari che inviò con la raccomandazione di unirsi ubbidienti a sant’Agostino di Canterbury che, dopo aver ottenuto il battesimo del re del Kent, Ethelberto (san Adalberto), nel 597, fece la sua parte con più di diecimila sassoni.
Sembra impossibile che tanto grande lavoro lo abbia realizzato un uomo di salute precaria, a volte obbligato a rimanere a letto per giorni e giorni. Morì il 12 marzo dell’anno 604. Giovanni Paolo I lo evocò, prendendo possesso della basilica di San Giovanni in Laterano, ripetendo le sue parole: “Sia vicino il pastore ad ognuno dei suoi sudditi con la compassione. E dimenticando il suo grado, si consideri uguale ai sudditi buoni, ma non abbia timore di esercitare, contro i cattivi, il diritto della sua autorità. Ricordi che mentre tutti i sudditi rendono grazie a Dio per quanto il pastore ha fatto di buono, non osano censurare quello che ha fatto di male; quando reprime i vizi, non smetta di riconoscersi, umilmente, uguale ai fratelli che ha corretto e si sieda davanti a Dio tanto più debitore quanto più impunite risultino le sue azioni davanti agli uomini”.
© Isabel Orellana Vilches, 2018
Autora vinculada a
![]()
Obra protegida por derechos de autor.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.
________________
Diritti di edizione riservati:
Fondazione Fernando Rielo
Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid
Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72
E-mail: fundacion@rielo.org
Deposito legale: M-18664-2020
ISBN: 978-84-946646-6-3